Barbieri, Sergio, I giorni dorati
Presenza e solitudine, Introduzione a Sergio Barbieri, I giorni dorati, Poesie anno 1985, Milano, Prometheus (Eos 18), 1993.
Testo della Introduzione
Nella raccolta di poesie I giorni dorati, il sogno si armonizza con la realtà in una scoperta – biografica e surreale – dei più intimi valori umani: intrascendibili, perenni, universali. Quasi in sogno – che penetra nella specificità fenomenologica del vissuto –, viene illuminata la ricchezza dell’incontro d’amore.
L’amore, in primo luogo e sostanzialmente, non è congiungimento dei corpi. È completamento di essenti. Unione-realizzazione della persona in quanto persona che è.
Nell’amore, in gioco è la personalità. E più ancora che unione, è riconoscimento di sé: l’amore genera la consapevolezza dell’io integrale e ne segna la misura totale:
«e pareva in attesa
delle bianche luminosità plenilunari…» (Quella prima sera).
La persona – l’essere che è per la coscienza di sé –, immersa integralmente nella autocoscienza, è proiettata in una dimensione nella quale, possedendosi, si vive come identità, senza dicotomia tra il sé e il fuori-di-sé. È la sensazione della eternità.
Normalmente, invece – quando l’uomo si imbosca nei chiaro-scuri del mondo -, coglie se stesso entro il flusso delle cose e si percepisce spezzettato nei vissuti: e vive la differenza. Non solo tra sé e il mondo: ma anche all’interno di sé. Non è un io che si possiede. Il suo tempo è il tempo delle cose, è la successione delle proprie relazioni con il mondo. L’amore, nel suo partorire l’autoidentificazione, crea
«un breve attimo della sua vita etema».
In questo dinamismo interpersonale, l’eros ha la funzione di approccio. In un punto del tempo cronologico,
«[…] non fu necessario
parlare ancora.
[…] una complice intesa
nei nostri occhi
e le tue mani […]
cercarono le mie» (Quella prima sera).
È così che si possono vedere
«crescere le stelle».
L’unione fisica non fa altro che esternare, oggettivandolo, il compimento interiore: allora quando
«non parlammo più […]»,
quando le stesse parole appartenevano ormai al fluire. Ora valgono ormai, solo
«esclamazioni di stupore»
per esplicare l’eterno calato nel tempo.
Senza questa «armonia dei corpi», quando l’amore è soltanto eros o «sogno» incompiuto, l’amore è gioco del tempo: che scandisce la sua fugacità.
«Non ci sono più i tuoi vestiti.
Non ci sono più le tue calze
abbandonate – come un burattino
dalle gambe spezzate – su quel
vecchio anacronistico tavolino.
[…]
Tu, tu non ci sei più» (Risveglio con incognita).
Altra esperienza. Altra fenomenologia esistenziale: nella quale non già il «sempre» e il «sé» realizzato, ma il «non più» è quello che prevale. A quel punto non basta più «un segno» a fermare due monadi incontratesi; non può esserci nulla che valga a fissare
«che tu poco prima»,
tu c’eri!
Così anche l’amore si sperde nel segno del tempo che rapisce
«i nostri ricordi
e i nostri sogni più belli» (Ieri ho letto nei tuoi occhi).
La vita conosce anche questa esperienza: la labilità dell’amore. C’è un amore agganciato a uno stelo: in una notte sotto un ciclo stellato. Si tratta di un appagamento che tiene le mani
«avvinghiate»
e che il «vento del tempo impietoso» allontana ed unisce, unisce e separa (Questa notte saranno in due a contar le stelle).
La vita comunque è soprattutto amore. C’è un amore che abbraccia tutte le cose e va oltre quelle specifico sentimento che possiamo dire sentimentale ed erotico. «Il tempo d’amare» – come s’intitola una poesia – non subisce le stagioni che passano, non ha tempi morti. Esiste da sempre. E vale per sempre: è 1a madre, il fratello, l’amico, «la ragazza che ti porti / negli occhi», è la natura ed il cane.
Vivere significa amare.
A parte l’eterna stabilità della coscienza d’amore, tutto l’arco esistenziale di questa raccolta si scandisce tra l’attesa e poi ancora l’attesa. Di contro alla primavera interiore che crea le «nuvole bianche» –nelle quali la mente riflette i pensieri –, il «gelo» solidifica come una Sfinge i bisogni del cuore e vi scava intorno una distesa di deserto infuocato (Il deserto senza fine).
La solitudine diventa così la condizione dell’uomo: essere soli è come essere unici al mondo (Quando si è soli)! Forse nessun altro stato d’animo costituisce, in negativo, il momento così totalizzante, bruciante come il sole, abissale come una vertigine: perché ciò che si perde è il proprio sé. Perso
«[…] nel nulla» (Le speranze del domani).
La solitudine «inebetisce» (Un cuore stanco): il cuore non sente, non capisce, non gioisce, non spera, non dispera (Cuore sordo), diventato un «automa», come recita il titolo di una poesia. Non sente, e non vede: come in un tunnel attraversato dal «buio completo». Eppure basterebbe una
«lucciola di giugno
una rosa rossa di maggio
un volo in seta nera
delle rondini di marzo…» (L’alibi di vita).
Basterebbe. Ma non basta!
L’autore non nasconde che questa è la sua situazione profonda:
«il deserto
che vive da sempre
dentro di me» (Sogni antichi).
Ci si può chiedere se il deserto sia la dimensione specifica dell’uomo. Sembra potersi rispondere di sì. Del resto già l’ha detto Quasimodo. Essere persona significa infatti essere in rapporto immediato solo con il proprio io. Con il mondo, umano oppure no, la coscienza è in rapporto mediato; e solo l’amore sentimentale unisce in una unica consapevolezza due coscienze – ed è davvero mistero dell’anima. Normalmente invece, ognuno ha il suo «sogno», il suo universo interiore, con il quale solo la coscienza sognante è a contatto diretto. L’autore in qualche modo lo proclama prendendo a prestito da Pavese – cui dedica una lirica – l’inizio di una poesia e di una raccolta:
«Verrà la morte
ed avrà
i miei sogni».
Questa consapevolezza di essere così solo, da apparire così «strano», è una conseguenza che l’autore sviluppa con lucida mente. E quale significato abbia per lui l’orgoglio di preferire questo «prezzo» a qualsiasi guadagno, risulta chiaro quando si comprende che «sognare» è la stessa cosa che realizzare autenticamente se stesso.
Già Heidegger distingueva tra la vita autentica, che è quella che realizza la propria «libertà» in cui consiste la coscienza – il «farsi» in assoluta autofondazione –, e la vita inautentica, sbriciolata nella «quotidianità» intesa come immedesimazione della coscienza con la realtà delle cose. Il Barbieri difende la sua libertà anche a costo di trovarsi sempre a inseguire «nuove chimere» (Colpi di tacco) ed esemplifica l’inautenticità nella omologazione con l’universo degli spot pubblicitari e della umanità inventata dai mass media («Vivi te stesso»): in termini generali, con l’alienazione dalla propria intimità da parte dell’uomo, per vivere così immerso nel mondo «cosale» (direbbe Jean-Paul Sartre), da identificare il bisogno di sé con le cose del mondo – una auto roboante, una nuova vacanza in esotici paesi, una lavatrice automatica, una tuta da ginnastica… Qui si tratta – interviene il poeta – «di estinzione di cervelli
e di sentimenti».
La vita della «illusione» è drasticamente contrapposta, dunque, alla vita del reale oggettivo: e all’alternativa di abbarbicarsi alle cose, diventando un tutt’uno con esse, l’autore preferisce «inoltrarsi in un deserto
per incontrare il suo miraggio»,
per non essere, come i molti, «un morto vivo», uno «zombi della Tv» («Vivi te stesso»).
Una cosa è certa: scegliere la libertà può essere entusiasmante, può anche definirsi un dovere dell’uomo, ma non è certo un viaggio piacevole. È un peso enorme: una fatica di Sisifo. La libertà è sempre al di là delle conquiste raggiunte: bisogna sempre attendere l’«angolo dell’ultimo / vicolo» (Colpi di tacco), non arrendersi mai, neppure nel vuoto più nero, nella speranza che torni ancora un cielo di aquiloni (La fine di un sogno).
«Il profumo della libertà», che dà il titolo ad una poesia, non è per nulla, dunque, un profumo di rose: Sartre diceva che la coscienza è condannata ad essere libera. Il che vuol dire che è intrinsecamente obbligata ad essere tale: non può farne a meno, in tanto in quanto è coscienza. Magari potrà essere una coscienza, per dire così, alienata: ma non può evitare di scegliersi, di crearsi dal nulla. Tuttavia, la condanna ad essere liberi comporta anche sofferenza e fatica, per chi si propone di assumersi il compito con tutto il coraggio e fino in fondo alle sue conseguenze. L’epilogo della libertà appare addirittura tragico ne Il profumo della libertà di Barbieri: una piccola talpa, insofferente delle immutabili regole del vivere secondo i ritmi imposti alla specie, arriva in cima ad una collina per scavare le sue gallerie; lì mette su una bella famiglia – e la sua compagna è persino invidiabile, perché sa anche tacere! –, ma neppure questo le basta; s’inerpica sulle rocce, sale sui picchi, fissa lo sguardo tra i cieli azzurri e verso il sole splendente, finché incontra la grande fortuna: la sua sete
«di verità e di luce
fu premiata dalla natura
benigna e madre»:
un falco la artiglia
«per portarla nel più alto
dei cieli
dove sfolgora la luce
e la verità»:
e dove un nido di falchi attende di mangiare la piccola talpa.
Non si può negare che il «prezzo» della libertà non sia caro: la libertà è consumarsi fino a morire. È accettare di annullarsi come creatura del mondo.
S’è detto che l’uomo, per essere libero, deve sempre aspettare. Ma a volte sembra che manchi la prospettiva futura: ed è questo il momento più problematico e, direi, vertiginoso della ricerca di una autentica realizzazione di sé. Un sogno può distruggersi d’un colpo, senza poterlo più riutilizzare per il proprio domani, come avviene per l’aquilone che, caduto in mare, è rovinato per sempre:
«E non potrà più
volare
alto nel cielo
della fantasia» (Due ragazzi corrono).
Eppure, benché sempre franto e sempre «caduto», il cuore non si ferma neppure all’«ultimo» sogno che ormai si è infranto: la speranza non cede le armi (Ho visto cadere un sogno). Neppure di fronte al pensiero della fine: anzi neppure nella morte (Addio giovinezza). È questo l’aspetto più veritiero e compiuto del senso del sogno. Il sogno non significa seguire chimere con gli occhi del mondo. Significa, invece, dare credito all’immortale tensione del cosmo – e dell’uomo in esso conchiuso e di esso partecipe – verso spazi esistenziali sempre possibili e sempre imprevedibili.
«Dietro la curva dell’infinito
[…]
C’è solo il profumo intenso
di una nuova speranza
di fede e di vita» (Dietro la curva dell’infinito).
La vita dell’uomo che cerca di realizzare la propria libertà – e cioè di diventare uomo davvero – è paragonabile a quella di un avventuriero. L’avventuriero è, in un racconto del Barbieri che chiude questa raccolta di poesie, l’uomo di sempre che tenta di essere quello che la sua natura gli impone. Ecco dunque che egli passa attraverso il Tempo, e vede i volti ed i corpi «invecchiare e sparire tra le nebbie del Tempo». È ovviamente un uomo solitario: che rifiuta di radicarsi nel fugace e non vuole generare figlioli. Rifratto nel mondo, l’avventuriero non si è neppure legato a qualche attività preordinata: muta ali, spazia in mille nomi e in mille volti, cambia continuamente maschera e interessi. Ma la sua vocazione più profonda, che infine lo ha trascinato in un deserto di «dune frementi sotto il sole implacabile dell’angoscia», è nelle «ombre cupe di caverne a scavare gli scheletri dei suoi primi sogni». Ed è da qui, da questo ritorno all’indietro di mille e mille giorni e mille anni, che viene il miracolo. Si tratta di quel miracolo di cui abbiamo parlato all’inizio: la sorprendente presenza di una donna che fa diventare «inerme poeta» un guerriero sempre inquieto alla rincorsa di qualcosa di nuovo. E per la prima volta ha accanto a sé
«due occhi splendenti nuova giovinezza e nuove illusioni» (pagine 7-15). [Francesco di Ciaccia]

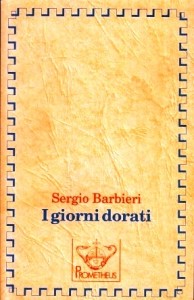
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.