Dornetti, Vittorio, Francesco d’Assisi
Un giullare per amico, Introduzione a Vittorio Dornetti, Francesco d’Assisi. Una santità laica, Milano, Terziaria (Il Periplo 5. Collana diretta da Attilio Agnoletto), 2001.
In copertina: Apparizione di san Francesco al vescovo Guido di Assisi (particolare), Firenze, Santa Croce, Cappella Bardi
Testo della Introduzione
Da quando la storiografia ha inscritto in modo esplicito l’esperienza di Francesco nel quadro socio-economico del mondo ecclesiastico, l’immagine del suo ideale ha guadagnato in autenticità.
Dopo l’approccio critico di Raul Manselli e di studiosi quali Giovanni Miccoli e Franco Cardini, è chiara l’intenzione dell’Assisiate di salvaguardare se stesso e i suoi seguaci dallo status socio-economico cui gli istituti religiosi erano pervenuti, fino ai suoi tempi, da sempre. Tutti. Persino i certosini.
Egli partì da un concetto semplicissimo: restare abbarbicati al vangelo. Puro e nudo. Era un concetto così scontato, in teoria, ossia a chiacchiere, che non c’era chi potesse contestarlo. Al punto che nessuno s’accorgeva che era obliterato.
L’idea forte della sua rivoluzione coinvolgeva alcuni cardini della configurazione del sacro e dello “spirito” quale s’era imposta in un Millennio. In sintesi: la distinzione teologica, giuridica, morale tra chierico e laico e la concezione ascetica delle virtù. E il suo terrore era per la connessione tra possesso di beni economici e dominazione sugli altri.
Lo spirito evangelico, nella sua essenza intima, è questo, e solo questo: la divinità si è fatta povertà, ossia abbassamento materiale in mezzo agli uomini. Ed è umiltà. L’umiltà si è proposta come comunanza di vita materialmente vissuta con gli uomini reali. Ed è la povertà.
Di conseguenza: la povertà non è di natura ascetica, individualistica, o virtù relegata nel cuore. È un dato materiale: è essere, per scelta di cuore, di fatto povero, tanto quanto lo sono i poveri concreti. E questa partecipazione è fratellanza. Umiltà reale.
L’umiltà, dice Francesco in Salutatio virtutum, “confonde la superbia e tutti gli uomini di questo mondo”. Perché? Perché è stare con gli esclusi da questo mondo. Quindi è “sorella” della povertà. E viceversa.
Le virtù cristiane, se sono solo idee e parole, servono ad imbrogliar se stessi e gli altri.
Francesco non lo ha denunciato a voce: lo ha indicato a gesti. Ed ecco, pur con tutta la riverenza verso il signor prelato, smantella, da impareggiabile giullare e quasi da istrione, il bel consesso di invitati raccolti in lauto convito (cfr. Leggenda perugina, 61): mette davanti al cardinale i pezzetti di pane nero che era andato, prima, ad elemosinare in giro, e li distribuisce ai signori commensali! Il signor prelato se la prende a male. Solo per un aspetto il gesto è risolto dal “semplicione” – così lo apostrofa lo stesso cardinale, contrariato – nei termini della povertà. Il messaggio è di significato più vasto e radicale, del resto intrinseco alla povertà quale era intesa dal gran contestatore: l’essere servus dei “servi di Dio” (il titolo è attribuito, per antonomasia, al vescovo di Roma) non ha senso, se è un concetto. Ha senso se, e solo se, è un fatto materiale.
Lo stesso per la fratellanza. Chi sconfesserebbe, e ora, e allora, il Cristo che ha dichiarato fratelli tutti gli uomini? Sul piano spirituale, ben s’intende. Ma appunto è qui il problema: come può essere fratello, e persino servo di tutti i suoi fratelli, uno che mangia e dorme da nababbo, mentre altri, che sarebbero non solo suoi fratelli, ma persino suoi padroni, riescono a stento a farlo?
Non è questione di tempi storici. Quella dei “tempi storici” è un’altra bella scusa, sempre pronta a giustificare tutto. È questione di forma mentis. Ho sempre in testa un episodio che mi ha scosso. Tempo fa, quando, fanciullo, facevo parte delle voci bianche del coro parrocchiale e si era andati, in pullman, in altra sede a cantare il pontificale, alla fine del rito un tale, che faceva parte della stessa cantoria, a causa di un disturbo fisico chiese al vescovo se poteva essere accolto nella sua macchina per far ritorno. Gli fu detto che non c’era posto. L’auto partì. Io mi accorsi che il posto invece c’era!
Formuliamo questa ipotesi: il vescovo, nel caso non ci sia disponibilità nella sua auto, cede il posto a un altro e prende, in pullman, il posto di quell’altro. Nella ipotesi, l’altro non è un prelato di maggiore dignità: è un qualunque uomo. Può accadere? Sì: ma è facile che quel vescovo sarà canonizzato. Sarà l’“eroe”!
Di norma conta il cuore! Così si dice. In realtà, chi ha potere sta sopra gli altri, invece che stare giù e sotto gli altri: e la sedia gestatoria (oggi eliminata, perché ostentare i simboli dello “star su” non paga più) lo simboleggia.
È il cuore, ciò che vale! In pratica, la finta. Negli anni della contestazione del ’68, tra i frati minori cappuccini, l’unico degli Ordini francescani a conservare ancora qualche seria norma sulla povertà, alcuni frati giovani non si capacitavano come ci si potesse ritenere poveri, se si godeva d’ogni bene, mentre la maggior parte dei mondani o secolari – come erano denominati i laici, la “comune gente” che non viveva “in povertà” –, neppure si sognavano ciò che i frati “poveri” avevano. A tale perplessità i confratelli anziani, peraltro quelli più coscienziosi e seri, rispondevano: «La povertà, basta che la coltivi tu, nel tuo cuor pio! La povertà reale è infatti una finctio iuris». Una finzione!
Esiste nell’astrattezza del diritto. E tanto basti!
Grazie alla “povertà nel cuore”, gli Ordini francescani sarebbero diventati anch’essi imprese per affari. Grazie poi all’“umiltà nel cuore”, si sarebbero fatti guerra per stabilire chi, tra loro, fosse più “francescano” o meno.
Questo capì Francesco: essere Cristo non vuol dire essere “il primo”. Ma “l’ultimo”. Essere Cristo non vuol dire essere “il meglio: ma “il peggio”, nella scala sociale, ecclesiastica compresa. Essere Cristo non vuol dire essere “il santo”. Ma essere “l’uomo”.
Era scelta di “minorità”.
Era la scelta di laicità.
Questo capì Gregorio IX, che conosceva molto bene l’ormai defunto gran contestatore: farlo, quanto prima, “santo”. Farlo diventare “eroe”!
Farlo diventare quello che Francesco detestava: l’eccezione! Farlo diventare colui che, sì, può essere imitato: ma come “ideale”! Ideale da raggiungere, sì: ma nel “pio cuore”.
In effetti la prospettiva più rivoluzionaria di Francesco fu la visione laica della santità. Il concetto richiederebbe un discorso approfondito, e questa non è la sede. Ricordo solo un tratto della sua anima, riferito dai biografi antichi: l’amicizia affettiva, ed effettiva, umana, con Jacopa dei Settesoli. Ne ho scritto un saggio su «Studi francescani». Quando Francesco, prossimo a morire, era condotto alla Porziuncola, non volle fermarsi da Chiara, a San Damiano: le fece pervenire solo uno scritto. Eppure Chiara, sapendolo gravemente malato, lo aveva insistentemente pregato perché andasse a trovarla! Raniero Cantalamessa, Predicatore della Famiglia Pontificia e mio veterano amico, volutamente disattende le fonti scritte e parla della visita di Francesco a Chiara in quel frangente, basandosi esclusivamente sull’affresco giottesco.
Perché la deliberata distorsione storica? Per concludere che Francesco coltivava solo amicizie “non umane” e “non guardava donna negli occhi”, nel senso affettivamente umano.
Ma stando per morire, appena dopo che non volle fermarsi a San Damiano, Francesco dettò una lettera per Jacopa, perché ella accorresse da Roma a spron battuto e gli portasse i dolcetti che ella – così si espresse –“era solita preparargli”, quando egli si fermava a casa sua! Ancora: le chiese di portarle un panno in cui avvolgere il corpo, una volta morto, e i ceri per la sepoltura. Forse i frati non l’avevano, il panno e i ceri per la sepoltura? È chiaro il distacco dai frati! Non solo. Fece vedere a Jacopa – a casa sua, è ragionevole pensare – le stigmate dei piedi e del costato: lui, che non voleva farle vedere ai frati!
Francesco era profondamente laico. Il fatto di non essersi fatto chierico è solo un segno. Denso di significati, sì: ma un segno dei meno rilevanti.
Vittorio Dornetti ha privilegiato in questo libro l’aspetto della santità laica di Francesco e d’alcuni indirizzi del francescanesimo delle origini, offrendo riscontri con la letteratura popolare. La sua indagine, ampia, approfondita e rigorosa, costituisce un nuovo approccio al tema francescano. Io qui accosto altre considerazioni.
Francesco capì che, all’interno dell’indiscussa religiosità sociologica, il diffuso allontanamento dal vangelo aveva come dinamismo di fondo il distacco tra ceto clericale (e religioso) e ceto dei “semplici fedeli”. In seguito, negli anni della contestazione del ’68 dello scorso secolo, i giovani frati francescani si rifacevano all’Assisiate nel propugnare per gli istituti religiosi una configurazione più laica.
Le implicazioni erano di vasta portata, ma qui faccio cenno solo di un aspetto di per sé secondario. La denominazione di “frates” voluta da Francesco implicava in primo luogo la parità tra i suoi seguaci: fossero chierici, o meno. Egli eliminava, anche in ciò, la distinzione vigente nei monasteri. Perciò, ad esempio, poteva assumere il compito di superiorato anche un non chierico. Quanto alla predicazione, ai suoi tempi poteva svolgerla anche un non chierico. Non era questione di tempi, né di nomi e neppure di cariche di governo: si trattava di affrancarsi dallo spirito della clericalità. Era precisa prospettiva di Francesco che la sua “famiglia” fosse contrassegnata dalla laicità.
Mi piace rammentare un episodio indicativo: Francesco dal Saladino. Sul suo significato in ordine allo spirito di pace e di fratellanza universale, s’è già detto quasi tutto. Io voglio ricordare che l’inusitato predicatore si premurò di chiedere licenza al legato pontificio, come di dovere; ma, avutane la classica risposta diplomatica – se l’aspettava, astuto com’era! -: «Non è il caso, ma, se tu vai…, io non so niente!», Francesco ci va. E come ci va? Privo d’ufficialità: ci va come essere umano. E proprio questo essere sullo stesso piano dell’altro – in cui consiste l’essenza della laicità di Francesco – costituisce il fondamento della sua fratellanza. Chiunque sia l’altro: credente o miscredente, ebreo, musulmano o cristiano, addirittura umano o animale.
L’altro episodio, questa volta favolistico, ideato dall’autore de I fioretti (cap. XXIV): Francesco accetta di giacere con la prostituta. Si sa: non per il sesso, ma per insegnamento. La invita a giacere sul fuoco. Anche in questo caso, l’agiografia ha esaltato la virtù del santo. Ma, al solito, non è la gloria di Francesco: quale altro cristiano si sarebbe messo a far l’amore con la donna musulmana, in terra infida, in clima di guerra armata?
La specificità di Francesco è in altro ambito di valori: egli le risponde, egli le parla, egli l’“accetta”, egli l’accosta come un semplice essere umano.
Come un laico.
Nessun tratto paternalistico: tanto “buono”, ma tanto, da “abbassarsi” persino alla comune gente!
E penso che proprio i laici lo abbiano capito di più. Col Saladino nasce una certa amicizia, di sicuro il profondo, sincero rispetto. La prostituta addirittura si converte. Il lupo di Gubbio lo ascolta. Vicino a morire, Francesco è criticato dal suo superiore frate Elia, perché, anziché cantare, si metta a piagnucolare per i propri peccati: la gente che sta fuori – spiega Elia – potrebbe trarne scandalo. Francesco dunque avrebbe dovuto metter su la scena della devozione! E invece che fa? Pur nella sua squisita gentilezza gli risponde, in buona sostanza, che pensi a sé: alla propria anima ci pensa lui da solo! E riprende a cantare – c’era anche Jacopa! Un particolare: allora le allodole si mettono a cantare. Gli animali lo hanno capito, Francesco. Meglio dei frati. Con argomenti che ritengo inoppugnabili, alcuni storici di primo piano hanno messo in luce come, in effetti, negli ultimi anni egli si sia in pratica separato dalla comunità dei frati.
A volte, nel corso storico, i laici hanno capito l’ideale di Francesco meglio dei francescani nei conventi. L’ho segnalato a proposito di D’Annunzio. Non mi riferisco alle sue fantasticherie, evidenziate nel titolo stesso del mio saggio, Attrazioni e illusioni francescane in Gabriele D’Annunzio, edito da «L’Italia francescana», ma ad esempio all’idea della forma di vita che egli tracciò come ideale delle discepole di Chiara: vivere nel mondo in povertà, mediante il lavoro manuale (La clarissa d’oltremare, redatto nel 1896). Ed era in effetti questa, l’idea di Francesco e Chiara (pagine 9-15). [Francesco di Ciaccia]

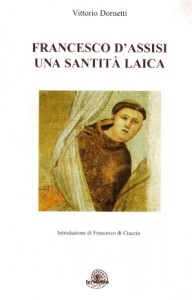
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.