Procicchiani, Teo, Nei buchi dell’esistenza
Teo Procicchiani, Nei buchi dell’esistenza, Prometheus, Milano 1992.
Testo della Introduzione
La poesia si può dire che sia quell’attività umana che non manca mai di stupirci.
Essa infatti fa riferimento al vissuto di un’anima con tutto il suo corredo d’esperienze affettive, mentali, biografiche e con le sue pulsioni inconsce, che nell’arte arrivano alla luce come da un abisso che non trova un altro sbocco se non nell’onirico. E già per questo motivo l’arte riconosce a se stessa quella libertà che la rende, appunto, imprevedibile e nuova. A differenza delle attività “pratiche”, l’arte non ha leggi. In tutte le operazioni che scandagliano e descrivono il “mondo”, in effetti – siano esse d’ordine fisico che di ordine sociale, storico, etico, ecc. –, possono essere originali gli esiti, possono cambiare il metodo e il procedimento, ma la prospettiva resta comunque legata ad un principio identico a se stesso: la razionalità.
L’arte invece è quell’attività in cui l’uomo dice “di sé”; non solo: in cui il “dire di sé” è nel modo secondo cui ciascuno “liberamente”, cioè senza rapporto con la logica, percepisce il “sé” che egli dice. L’arte è dunque alogica: il suo modo di conoscere il “sé” è emozionale e intuitivo. Non solo: è in qualche modo “magico”, nel senso antico del termine inteso come immediato contatto con la propria anima conscia ed inconscia e con tutto ciò che in essa è racchiuso, dalla vita degli esseri inanimati allo spirito degli antenati, dagli influssi astrali alle paure e alle speranze di tutti gli uomini di un’epoca.
E proprio quest’ultima dimensione arcana e proteica della poesia fa parte delle acquisizioni della cultura contemporanea, a partire soprattutto dal decadentismo francese di fine Ottocento.
Ma prima di procedere con qualche indicazione storica, è bene ribadire che l’attività dell’artista è un dire “di sé” anche quando egli tratta del mondo esterno – come nella linea cosiddetta oggettiva. Non è un mistero il fatto che, ad esempio – e qui mi piace toccare un limite a scopo didattico -, anche solo nel fotografare, per spinta ispirativa, la realtà con la macchina fotografica, ognuno produrrà un’opera d’arte solo se si occuperà di una realtà che egli ha esistenzialmente interiorizzato. Perciò, anche se il realismo offre dei canoni oggettivabili e generalizzabili, non si può impedire che l’arte sia soggettività.
Queste considerazioni sul realismo ci conducono ad un altro aspetto essenziale dell’arte: quello dell’“esprimere”. È il problema del mezzo espressivo. Le concezioni novecentesche della vita interiore dell’uomo hanno condotto verso una poesia che diventa sempre più espressione di una vita “segreta”: quella che il soggetto stesso non conosce neppure, perché inabissata in un inconscio ancestrale, o prenatale, o magari epocale. La poesia come “luogo del disvelamento” di ciò che è velato: così come il sogno del dormiente. E in effetti la poesia si è spesso avvicinata, in questo nostro secolo, all’onirico, oppure a quegli stati di stordimento nei quali emerge il “non saputo”, emerge ciò che la ragione censura e cancella. Nei sogni che facciamo di notte, chi non ha almeno qualche volta ravvisato una trama di immagini – “parole” del sogno! – che svelano la “verità” del proprio animo, oppure le pulsioni di un’intera generazione infiltratesi e penetrate nell’inconscio? Forse, il poeta è colui che questa esperienza la fa ogni notte.
Da ciò discende che il linguaggio in poesia – come nell’arte in genere – si è fatto nel Novecento sempre più criptico, ermetico: parole – come le immagini oniriche – che scaturiscono da un abisso scavato dalla tensione esistenziale, da una impellenza preaffettiva che si è maturata, sì, fino alla illuminazione di sé, ma non attraverso o nella consapevolezza logica. Ne consegue che la parola non rispetta più le leggi della coscienza razionale.
Un primo passo in questo senso fu compiuto da Gian Pietro Lucini ne Il verso libero del 1908; ma poi la poesia procedette con ritmi incalzanti verso non solo una scarnificazione linguistica, una congestione semantica – parole pregnanti con una indecifrabile significazione –, e una rivoluzione formale, ma anche verso una sempre più fluida demarcazione tra sogno e realtà, tra immagini oniriche e rappresentazione reale, e tra la “cosa” (del mondo, o il “noi-io”) e la “coscienza” (o l’“io”). Dalla poesia di un Dino Campana, di un Clemente Rebora e di un Arturo Onofri, poi attraverso la maturazione della poesia – io direi – metafisica di un Ungaretti e di un Quasimodo, la storia della poesia nel Novecento tende a negarsi come “estetica”, a sciogliersi in scrittura automatica, quasi che lo scopo della poesia sia quello di “sperimentarsi”: sperimentare innanzitutto l’ardua – o impossibile? – decifrazione tra caos e cosmo, tra razionale ed irrazionale. Ed anche questo rientra nella “libertà” della poesia. nella sua natura di essere il titanico sforzo di disvelare la “verità”. Malgrado si debba constatare che la verità è sempre “al di là di”, anche al di là di se stessa.
Queste premesse valgono ad inquadrare la poesia di Teo Procicchiani nel filone dello sperimentalismo espressivo, posto che il suo interesse non è per le “cose che accadono”, ma per la forma esistenziale con cui accadono.
Ed appunto, anche in alcune liriche tematicamente, il suo assillo appare quello del “dire”, del far parlare la coscienza al contempo intimorita nell’esser nel mondo e incatenata all’esigenza del comunicare. Ma se la ricerca linguistica è un’ansia di fondo, “un matrimonio non è la mia storia”: l’autore è consapevole che la ricerca della propria parte “consorte” – cioè di quella parte di sé che raccoglie il vissuto estrinsecandolo – deve andare avanti, “e forse mi sposerò / all’improvviso / con parole migliori”; ma anche che ogni scelta è come l’amore sensuale: si entra nella sfera del comunicare, ma per ricominciare a riconoscersi ancora e sempre. Di attimo in attimo, l’autore non può fare ogni volta che una sola operazione: rovesciare “le impressioni”, e ridere. Ridere di sé e della parola stessa, “violentando / i segni”: consapevolezza del limite in cui si è costretti, per superare i quali è necessaria questa “violenza”. Che però non basta: il poeta sa che non può mai “dire” del tutto se stesso, “esprimere / il mio cuore moribondo” (Espressione). Egli lo afferma chiaramente in Descrizioni impossibili, in cui alla violenza si sostituisce il “gioco”, simile al ridere, “con parole affastellate” e “in equilibrio / spinto all’estremo”.
Significative per lo sperimentalismo mi sembrano in particolare le liriche Il sospetto e Festa, in cui sono intenzionati – mi pare – sentimenti e accadimenti reali. Lo stato d’animo del sospetto è plasticizzato nelle gambe che si piegano incollate al corpo e nelle braccia che assalgono il torace: atteggiamento interiore ed esteriore, l’uno simbolo e segno dell’altro. Così, in Festa, l’attesa”, che è “parcheggio di odio / momentaneo” e “d’indifferenza accelerata”, offre immagini riottose all’oggettivazione, che tendono invece a catapultare il significato ad esperienze interiori impenetrabili:
“L’aria umida
calda e sola
avrebbe la costante
disperazione
per insinuarsi
a larghi fiotti
nell’insulsa attesa
della festa […]”.
Il fulcro dell’intuizione poetica di tutta la raccolta sembra che sia da individuare nell’esistenza: esistenza come esistere, nel senso dell’essere che continuamente nasce dai “risvegli” e continuamente “corre” e si “sorpassa” (Voi). Questa dimensione dell’esistere è misurata nel rapporto con gli altri, con il “voi” – così nella lirica omonima –: nello scambio delle sensazioni e nella dialettica dell’incontro la coscienza tocca le punte dello smarrimento: la “mia vera paura” è nelle “tracce estinte”. Condannata al continuo mutamento, la coscienza non ha riposo in questo suo inesausto inseguirsi: ha invece pace nelle “soste” – definite “inebrianti” –, quando l’uomo, per un istante quasi magico, si sente identificalo con se stesso. Ed è proprio allora che accade il miracolo della progettualità – come lo chiamò l’esistenzialismo -: “vivere in anticipo / i nostri giorni”. Progettualità esistenziale, ho detto, e non anticipazione immaginaria. Si tratta infatti di una “continuità” del passato nel futuro; o meglio del futuro nel passato: la coscienza esistenziale si progetta in “avvenire”, cioè in un futuro che “viene verso” il presente, e che viene secondo quell’apertura alla vita che la coscienza ha avuto nel passato.
In questo impianto tutt’altro che immaginifico e speranzoso, l’autore non pecca certo di euforia. Egli sa che le “false speranze” hanno avvinto la coscienza “senza pause”: “ombre / di un giardino / incantato / che splendono / di vane promesse” (Solo noi). Anche nei barlumi di autobiografismo l’autore si sente assediato dalla fugacità, dalla fallacia dei giorni e delle opere. In Saggezza ad esempio l’abbraccio è “oltre i cancelli / dove fuggono / foschi ideali”, è cioè nella separazione, quando il progetto esistenziale è il vagabondare “senza tregua”. Ed è proprio la “mano / che ti ha stretto” ad aver dipinto i foschi ideali. Il che non vuol dire affatto cinismo. Tutt’altro. È compartecipazione ai brandelli si storia e di vita:
“nella felicità
mi hai chiamato
ed anche in questo
tempo d’angoscia
ti seguirò
nel tormento”.
Né la coscienza della precarietà è aridità o astrattezza. Tutt’altro. È speranza di aprire per sé e per gli altri un varco attraverso quello spessore del mondo che sembra non offrire nulla di sicuro, nonostante si sappia che neppure questa speranza basta alla vita:
“Ed anche noi, che non
siamo ancora stanchi
di bere speranza
a grandi sorsi continuiamo
un esercizio
che alla vita non basta” (Riuscire a ricordare).
È in questa lirica che si trova l’espressione che dà il titolo alla raccolta. Il bene è nei buchi dell’esistenza. È lì che c’è l’“acqua calma e limpida”, nel mezzo di “contorni labili e nervosi” della vita. E quest’acqua limpida non è programmabile. Nella cultura del nostro secolo, l’uomo ha capito che solo dall’intimo esistenziale discende il valore della vita reale. Ma se la programmazione è possibile e doverosa per le attività pratiche, per quanto riguarda la vita interiore, e cioè per il vissuto coscienziale coi suoi contenuti di umanità, ci può essere solo la tensione progettuale. Per il resto “non pensiamo a dove andiamo” (Notte).
Stringerci le mani, e poi arrivare dove “non sappiamo”. L’essenziale è “credere” che, a dove non sappiamo, arriveremo. Con le mani strette l’uno nell’altra.
È “notte”. Poi l’aurora ci sveglia dove ci ha condotto amore (pagine 5-11) . [Francesco di Ciaccia]

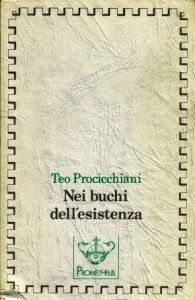
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.