Villa, Corrado, Racconti in chiaroscuro
Il presepe della vita, Introduzione a Corrado Villa, Racconti in chiaroscuro, Prometheus (Le rune 20), Milano 2010.
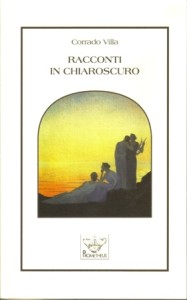
In copertina: Alphonse Osbert, Sera antica, 1908, Musé du Petit Palais, Parigi
Testo della Introduzione
“Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco – così tramanda Tommaso Celano, nella Vita prima di san Francesco d’Assisi – disse ad un suo fedele amico, Giovanni: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello»”. Giunta la notte di Natale, dai casolari della regione arrivano a Greccio, dove è stato preparato il presepe, uomini e donne, portando ciascuno ceri e fiaccole per illuminare quella notte.
Giunge infine Francesco, ed allora “si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello”.
L’idea di Francesco non era quella, come alcuni hanno ritenuto, di introdurre un rito, una nuova cerimonia religiosa. Egli, l’inventore del presepe, aveva l’esatta e precisa intenzione di vedere realmente, vivendola attraverso una rappresentazione scenica, la situazione vissuta dai genitori di Gesù nella circostanza della nascita del bimbo. Secondo illustri francescanisti, egli, al contempo, voleva proporre una “visitazione alterativa” di Bethlem: sostituire il pellegrinaggio in Terra Santa, per la cui conquista cristiana si combattevano tante battaglie, si spargeva tanto sangue e si disseminava tanto odio tra i popoli, con un allestimento scenografico della “Natività” nelle stesse terre in cui ci si trovava a vivere quotidianamente.
Il messaggio francescano, insito nell’invenzione del presepe, non è senza attinenza, per parallelismo, con la “sostituzione immaginativa” della realtà da parte dell’invenzione artistica, la quale crea un’opera che sta al posto della realtà del mondo e la ripropone, al contempo in modo effettivo e affettivo, reale e fantasioso, ricostruendola e interpretandola. Il termine poesia, in effetti, nel senso sostanziale di invenzione artistica, traduce il greco poiesis, che deriva dal verbo poieo, che vuol dire “fare”, “creare”, “compiere”.
I racconti della presente raccolta si offrono al lettore come una scenografia della realtà del mondo, ovvero di alcune sfaccettature della vita, al contempo fedele nella credibilità realistica e immaginifica nella trasfigurazione mentale. Sono come uno sguardo sul mondo, concretizzato per l’appunto nella forma di una duplicazione immaginativa. Essi appaiono come un presepe della vita, e non a caso hanno inizio con un testo che ripropone l’episodio della natività (con l’iniziale minuscola) di Gesù (Una notte di Efrem: il contadino).
Se Francesco d’Assisi ricorse alla riproduzione delle condizioni fisiche e ambientali della Natività per vedere, materialmente, la condizione di povertà della famiglia di Gesù, Corrado Villa ha compiuto – nella “parola” – la medesima operazione, ma riportando il lettore al tempo stesso e nei luoghi stessi in cui l’evento si compì, con le stesse connotazioni esistenziali e reali dei protagonisti dell’epoca e immaginando la situazione quale dovette verificarsi nella sua fattualità naturale, indipendentemente da interpretazioni religiose. L’ambientazione non è infatti quella di una storia sacra, prodigiosa, a parte la stella cometa, la quale, pur ricondotta a “fenomeno naturale” – che “si ripeteva con regolarità a distanza di diversi anni e […] era prevedibile con largo anticipo” –, risulta comunque un fatto eccezionale – “Per la stragrande maggioranza degli abitanti di Bethlem, si trattava in ogni caso di un’apparizione magica” – e quindi costituisce la spia di una valenza straordinaria dell’evento. L’ambientazione è quella di un normale caso di una coppia di sposi che, non avendo trovato altro posto nel paese agricolo qual era Bethlem in Palestina, in cui erano giunti da Nazareth per il censimento, trovarono ricovero provvisorio, date le circostanze della gestante, nella stalla di un vecchio casolare abbandonato, in cui l’asino era quello usato per il viaggio. Il realismo della riproduzione “storica” trova nella fantasia – sempre nel senso dell’invenzione poetica – la libertà di rinvenire un aspetto essenziale di tutta quella vicenda: la carità, spontanea, immediata, cordiale, del contadino il quale, avendo notato quei poveri individui in condizioni precarie, arriva a convincere i propri familiari a portare loro qualche panno e un po’ di cibo, imitato poi dai buoni e semplici pastori del luogo. Del resto, il titolo del racconto stabilisce come personaggio principale il contadino, spostando la centralità dell’accadimento dalla famiglia nazarena del neonato ad un qualunque e comune lavoratore della campagna. Anche questo particolare concorre a fissare il racconto nella cornice di presepe della vita.
La preoccupazione dell’Autore non è, direttamente, moralistica. L’attività dell’artista è quella di compiere l’invenzione, non quella di insegnare o di educare. Tuttavia ogni autore, esponendo i vari atteggiamenti e comportamenti, manifesta quasi necessariamente il favore o il disappunto verso alcuni di essi o verso altri; e il nostro Autore non manca di manifestare, più volte, sue indicazioni riguardo alla condotta umana, come fa anche in questo racconto. Quando il contadino esprime in famiglia il desiderio di portare del cibo ai viaggiatori nazareni – Giuseppe e sua moglie Maria –, rinunciando persino al proprio pasto, suo padre, il vecchio Eloe, osserva che, “con tanto cuore e poco cervello”, come del resto era stato lui stesso per tutta la vita, anche il figlio si sarebbe ridotto a vita magra; ma il figlio replica: “«Padre, non dire così: so benissimo che se potessi tornare indietro, rifaresti comunque i gesti di generosità che ti hanno sempre contraddistinto”».
«Non lo so, figlio mio: diventando vecchi si diventa anche un po’ più egoisti. Ma tu fai bene a fare quello che ritieni giusto. E quindi va’… va’ a portare cibo e coperte ai nazareni»”.
La riformulazione del presepe di Greccio compiuta da Francesco d’Assisi si propone in un altro testo, proprio “nella selva di Greccio in quel 25 dicembre 1223”, come è esplicitato nella chiusura del racconto La notte speciale di Gigio. In questo episodio, il protagonista è un asino, il quale è condotto dal suo padrone nel posto in cui dagli abitanti del luogo viene allestito il presepe vivente – con un “san Francesco” in saio – quale quello ideato, appunto, dall’Assisiate. Il nucleo dell’invenzione è la gioiosità, la festosità, la letizia, persino l’abbondanza, con tanta luce, con tanti ceri, con tante fiamme – allegrezza e luminosità che costituiscono un elemento importante anche nel racconto di Tommaso da Celano sul presepe di Francesco d’Assisi –; ma è singolare il fatto che, qui, in Corrado Villa, il soggetto principale dell’atmosfera gaudiosa sia soprattutto l’asino: il quale si gode una giornata eccezionale, priva di stenti e di fatiche, piena di attenzioni e di particolari premure del padrone, benché fosse in genere trattato bene (“«Ti striglierò fino a farti diventare l’asino più bello di tutta la regione… Mi farai fare bella figura, lo so… d’altra parte tu sai che io ti tratto bene, vero…»”). Se questo non è un insegnamento espresso, è tuttavia un forte richiamo alla visione di Francesco d’Assisi – al quale esplicitamente fa riferimento il testo – secondo cui la “fratellanza” è universale: unisce non solo gli esseri umani tra loro, ma anche gli uomini e gli animali. Anzi, tutti gli esseri viventi, e anche non viventi, come il nostro “fratello sole”, la nostra “sorella luna”.
Per un ulteriore sguardo sul mondo, si ripropone ancora il tema del presepe: uno sguardo ancor più eticamente orientato (La statuina). È la storia in cui, in un presepe sfarzoso, viene a mancare il “bambinello” d’oro massiccio, dagli occhi di smeraldo: “Statuine artigianali in oro, argento, in finissima ceramica smaltata e dorata, in ambra, avorio o prezioso legno d’Ebano e Tek erano state utilizzate per la realizzazione del presepe più sfarzoso che si ricordava a memoria d’uomo”. Si tratta di una “mostra, che avrebbe aperto i battenti a Roma a partire dall’Epifania del 2001, […] ideata quale nuovo richiamo di pellegrini nell’anno postgiubilare” (con chiara allusione all’uso economicistico del presepe). Se la collocazione temporale può essere fantasiosa – ma l’impianto generale delle “storie” del Villa fanno sempre presumere, tuttavia, che ci si riferisca a qualche dato concreto –, sul piano della contrapposizione sociale e ideologica è del tutto fattuale l’intreccio-contrasto con la parallela “storia” del bambino africano, poverissimo, solo, abbandonato e malato che, in Africa, costruisce una statuina di fango dalle fattezze d’un bimbo. La mala sorte, ossia un incidente casuale, vuole che il bambino, inciampando, faccia cadere sulla terra melmosa la statuina, che ben presto si confonde col fango ed al fango ritorna. La sorte magica, però, vuole che egli scopra, nella medesima terra in cui è caduto il suo manufatto, una statuina di bimbo bianco, dagli occhi verdi come smeraldi. Di là, nella sua lussuosa dimora, il proprietario del presepe, “l’ultimo anziano rampollo di un’antica casata di nobili spagnoli che nei primi anni del novecento aveva ritenuto opportuno rinvigorirsi economicamente per mezzo di vincoli matrimoniali con la nascente ricca borghesia”, viene a scoprire che nella teca in cui era scomparso il bambinello d’oro si trova un qualcosa di ben diversa natura: “una sostanza che non poteva trovarsi nella teca: del fango bagnato”.
Se a volte, come in questo “presepe”, la lezione morale si ammanta di un gioco, come allo specchio, di riflessi e rimandi – narrativamente efficaci e coinvolgenti –, in altre storie si assiste ad una narrazione che ha il sapore di una quasi trascrizione dell’evento. Ne Il quotidiano incubo l’arte si fa – per così dire – materica, strettamente realistica, e nella registrazione delle voci, delle frasi degli ossessionanti accattoni snocciolate alla popolazione viaggiante, delle imprecazioni pensate contro i vicini appiccicati come sardine nella calca metropolitana d’una città come Milano, si ha l’impressione, fisica, di trovarsi esattamente su un treno nelle ore di punta.
Fantasia e realtà, qui, coincidono, come quando certe situazioni della vita difficilmente si potrebbero fantasticare. Il presepe della vita, ovvero di certi scorci della vita associata, in questi casi è la vita stessa trascritta fedelmente.
A volte c’è l’esigenza, però, di una impostazione più complessa, con il ricorso al “gioco delle parti”, che pur mette in scena – come ha insegnato Luigi Pirandello – la vita in alcune sue complicazioni più eccentriche, a volte beffarde, a volte tragiche, a volte ridicole. L’incontro-scontro, casuale, con una ex amica, in una frenetica Milano affaristica, permette i risvolti ambigui, da una parte, dell’ex innamorato di sperare “di riaccalappiare una vecchia preda” – che però nel frattempo è diventata funzionario di Polizia –; dall’altra, dell’ex amica di scoprire che quel vecchio amore, che magari sarebbe potuto diventare un semplice amico, nel frattempo si è dato alla delinquenza ed al crimine (Come ai vecchi tempi).
Il surreale, poi, in alcuni testi si manifesta potentemente nel gioco meraviglioso e incantato, ma anche angoscioso e drammatico, che sta tra il vissuto onirico e il vissuto quotidiano, tra il sogno e la realtà. L’amore tra due cuori – enfatizzato dall’assonanza con quello, dantesco, di Paolo e Francesca, a causa dei rispettivi nomi dei protagonisti – approda a una dolorosa constatazione, quando il protagonista si sveglia dal sonno – mentre nel sogno sta per incontrarsi con l’innamorata – e si rende conto che in realtà si trova in Somalia, nel deserto, come soldato in missione di pace (Il deserto dentro). Il titolo e il senso finale d’angoscia richiamano alla mente, per l’appunto, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, ma l’accento è posto, nel racconto di Corrado Villa, sulla discrepanza tra l’esistenza condotta in famiglia – pur con tutte le traversie che la vita può comportare e gli imprevisti che la vita può riservare – e l’esistenza trascinata in un paese soffocato di sabbia e di tremore, cioè tra due concrete condizioni di vita effettiva.
Il culmine del fantasmatico, in cui l’Autore tocca l’apice dell’immaginario, è entro il rapporto uomo-donna, non al livello dell’innamoramento, ma al livello della sponsalità consolidata. Del resto, nel suo precedente libro, la raccolta poetica Semi di vita, l’Autore aveva già insistito su questa tipologia di rapporto, scrivendo liriche che dell’amore coniugale focalizzavano la solidità granitica, la profondità abissale, la perpetuità durevole come vera e propria eternità. In una specie di “oltre la vita”, nel racconto emblematicamente intitolato La vita ed oltre, l’unità intrascendibile tra i coniugi che perdura anche dopo la morte è rappresentata attraverso un espediente, direi, toccante e geniale: l’uomo con il quale la consorte supersite intrattiene un’amicizia cordiale si rivela, alla fine, essere proprio lui, il marito defunto.
Su questa linea narrativa tra il surreale e l’onirico – poiché tutto potrebbe rientrare nella sfera del sogno, quale è espressamente sfruttato nell’episodio del soldato in Somalia (Il deserto dentro) –, si colloca il grande affresco della desolazione della morte. L’aspettativa, macabra, terrificante, che desta L’ultimo resoconto è quella della desolazione universale, della morte imminente di tutti gli esseri umani, se non fosse che, invece, si tratta dei misteriosi decessi tra gli abitanti di un paesino. Nel racconto, i termini della vicenda si articolano come assolutamente realistici – l’indicazione geografica (“nella bassa provincia mantovana”); il fatto che se ne sia occupato un giornalista; l’individuazione della persona che fu la prima testimone della ecatombe –, ma la storia della moria generale dei trecento abitanti del paese conferisce all’accaduto un alone apocalittico, confermato da sensazioni come la seguente, messe in primo piano dal narratore: “Una strana immobilità e pesantezza nell’aria si percepiva anche nell’interno della vettura malgrado l’impianto di aria condizionata; tutto attorno il silenzio palpabile e la assoluta assenza di forme di vita davano al paesaggio un senso di irrealtà”. Dunque, l’impostazione cronachistica trascende in una dimensione che pare metafisica, come quella della “peste” nell’omonimo libro di Albert Camus. La valenza metafisica di questo “orrore” è sollecitata non solo dalla improvvisa morte collettiva – che fa venire in mente la tragedia di Pompei (“Nel locale, in innumerevoli posizioni, vi erano cadaveri putrefatti accomodati come normali avventori; i resti del barman ciondolavano nei pressi della macchina da caffè; per tutta l’aria miliardi di mosche ed insetti vari rendevano apocalittica l’intera scena […]”) –, ma anche dall’ansia che coglie i personaggi.
Quest’ansia – l’angoscia della morte – è alla base dell’anelito alla immortalità, che ha sempre sospinto l’uomo a crearsi un “futuro” oltre la morte. Corrado Villa illustra questo desiderio – e bisogno – attraverso un resoconto cronachistico proiettato nel futuro: fino al 2093, partendo dal 1993, in Cento anni di cronaca giornalistica, appunto. Se le religioni immaginano mondi ulteriori a quello presente – e molti popoli antichi, tra cui gli egizi, corredavano le tombe di ciò che simboleggiava la continuazione della vita dopo la sepoltura –, la scienza cerca soluzioni concrete, fattive: l’ibernazione. Sembrerebbe che l’uomo debba poter arrivare a tale conquista. Ma è un miraggio, secondo il nostro Autore. Anzi, un disastro. Nel 2093, appunto, la Base del “Progetto Risurrezione” esplode miseramente. Dunque, “Per la risurrezione ormai si dovrà fare affidamento solamente sulle religioni che la promettono da millenni”.
L’interesse di Corrado Villa è orientato, in misura considerevole se non prevalente, verso la fenomenologia della vita quotidiana, verso la vita concreta, riguardata comunque con occhio attento alle dinamiche interiori, alla psicologia umana. Tale sensibilità si rispecchia, oltre che nelle liriche del precedente suo libro, Semi di vita, anche nei racconti qui raccolti. Per tal motivo, essi potrebbero definirsi anche uno sguardo interiore sulla vita di uomini e di donne. Nell’avventura umana, si svolgono in genere vicende normalissime, quelle che potrebbero dirsi le “comuni cose quotidiane” di gozzaniana memoria, anche se non “di pessimo gusto”, come amava pensarle Guido Gozzano stesso. Vediamo snodarsi, come davanti agli occhi, semplicissimi avvenimenti di tal genere – arricchiti in flash back da altri avvenimenti del passato – ne Le 5 e 12 minuti, il cui l’epilogo, tuttavia, conferisce una dimensione drammatica al racconto. Ma nella vita umana nel mondo – in questo mondo che dona e regala, a volte, dolci esperienze, tanta gioia e bellissimi esempi d’amore, ma che a volte distribuisce e semina terribili violenze e disperazioni profonde – si trovano anche soprusi del “forte”, come a volte viene qualificato – in realtà, del vigliacco – sul debole. E la vittima non si sa in quale baratro possa andare a finire. Una vita segnata, che conclude la presente raccolta, lo narra. E si vorrebbe – a me è accaduto così – non procedere nella lettura: per non essere avvinghiati, dentro, da una morsa di rabbia e di sofferenza. Il presepe della vita – di uno squarcio di vita infame – rappresentato da questo racconto fa venire in mente, per stare nell’allegorico, la “strage degli innocenti”.
La funzione dell’arte è quella di rappresentare la vita: la vita nella sua interezza. E il compito dell’artista è quello di salvare – per farlo rivivere – tutto ciò che dell’uomo esiste ed è esistito: salvarlo dalla distruzione dei “falò”. Forse, a questo messaggio rimanda l’Autore, quando, al termine del racconto del giovane vessato, desolato e morituro di Una vita segnata, scrive, dando la voce al protagonista: “Termino qui la mia storia, anche perché faccio sempre più fatica a vergare questi fogli che, probabilmente, verranno distrutti nel falò di tutti gli effetti personali, subito dopo il mio funerale” (pagine 5-14). [Francesco di Ciaccia]

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.