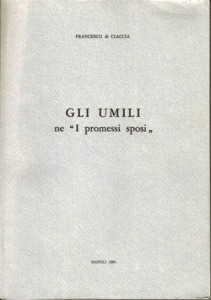1984 – Gli umili nei Promessi sposi
Gli umili ne “I promessi sposi”, Napoli, Studi e Ricerche francescane, 1984, pp. 126.
Presentazione
La categoria sociale degli “umili” nel romanzo manzoniano è stata ampiamente studiata dalla critica letteraria, poiché la sua rilevanza ne I promessi sposi ne costituisce una delle caratteristiche principali, come era stato già messo in luce, tuttavia con disappunto, da Nicolò Tommaseo, nell’Ottocento. L’aspetto sociale, cioè l’appartenenza ai ceti meno elevati nella sociatà, costituisce tuttavia solo una dimensione della “umiltà” nel romanzo manzoniano. In questa sfera di personaggi “umili” vanno considerati anche coloro che si collocano in una condizione subalterna per scelta etica o religiosa: i personaggi cappuccini.
Franco Buzzi, in «Idea», Anno XLI, 1985, n. 4-5, pagina 55.
L’introduzione, che dà il titolo a tutto il saggio, focalizza alcuni personaggi ed episodi, studiati analiticamente, che spiegano il senso della «minorità»: che si definisce, non sociologicamente ma evangelicamente, nella «fraternità», umile e generosamente obbediente ai fratelli. Alcuni punti della sezione prospettica riescono ad approfondire intuizioni più o meno veloci, in genere, lanciate dalla critica, e riequilibrano giudizi spesso distratti. La sezione peculiare, sui personaggi «minori» cappuccini (pp. 56-126), si avvale di riscontri storici, archivistici e letterari. Le interpretazioni dello studioso capovolgono in diversi casi quelle della critica corrente e si attengono al testo manzoniano con un’attenzione valida anche come metodologia critica; esse tendono, sempre, a scavare nella prospettiva dell’autore, psicologicamente e storicamente, così da presentare una lettura sollecitante ed originale, e sempre solida, non solo dei personaggi in oggetto, ma anche dell’universo mentale del Manzoni. Franco Buzzi
Giuseppe Santarelli, in «L’Italia francescana», 1 (1985), pagine 123-125, recensione di Francesco di Ciaccia, Gli umili ne “I promessi sposi”, Studi e Ricerche francescane, Napoli, 1984, pp. 126.
Nella storia della critica della letteratura italiana due sommi autori sono stati sottoposti spesso a contrastanti valutazioni per il mondo ideale e religioso che informano i loro capolavori: Dante e il Manzoni.
È stato detto che la vita dei santi può essere scritta solo da chi ha avuto una pur minima esperienza di fede. Ed è probabile.
Altrettanto si potrebbe affermare per chi si accosta all’opera di Dante e del Manzoni. Se quell’esperienza manca, occorrerebbero almeno la sensibilità e l’umiltà che si riscontrano, ad esempio, nel Momigliano.
Queste riflessioni sorgono spontanee man mano che ci si inoltra nella lettura di Ciaccia, il quale sa operare un approccio critico col testo de I Promessi Sposi sempre aderente al «vero» ideale e storico, con un rispetto esemplare – che dice condivisione – per il mondo religioso del Manzoni. Egli sa cogliere, in profondità, anche nei più segreti sottintesi, l’universo ideale del lombardo.
Il discorso critico del di Ciaccia si appunta su gli Umili ne «I Promessi Sposi»: e gli umili sono in particolar modo i cappuccini. Un discorso articolato, che si apre a tentacoli per risucchiare le varie opinioni critiche sui molteplici aspetti inerenti al tema, le quali vengono passate al vaglio di un giudizio lucido e sincero. All’accortezza critica fa così riscontro la grande conoscenza bibliografica sull’argomento, per cui le conclusioni, aderenti al testo manzoniano, appaiono convincenti.
Il critico trova la chiave interpretativa per intendere la presenza, il significato e il ruolo degli umili nel romanzo «nella morale del Manzoni», che è «quella dello ‘scandalo della croce’» e «del Cristo povero», un presupposto che la critica marxista e laica, compresa quella del Moravia, del Giudici, del Russo, del Noferi, ecc., trova difficoltà a intendere in tutto il suo spessore ideale. Di conseguenza, quella critica talvolta non riesce a intendere pienamente il mondo dei cappuccini, il cui ideale è la minorità, nel senso evangelico di umiltà e povertà.
Non è possibile in questa sede ripercorrere analiticamente il discorso del di Ciaccia, ricco di citazioni da fonti francescane e cappuccine, da studi storici e critici e soprattutto denso di riflessioni. Comunque, è subito da dire che non gli è sfuggita nessuna presenza significativa dei cappuccini nel romanzo, né in riferimento ai gruppi, né ai personaggi.
Egli si è documentato non solo a livello di ricerca erudita, ma anche, come sottolinea più volte, sperimentando nelle varie fasi della sua indagine, condotta anche nelle biblioteche conventuali, talune espressioni esistenziali dei cappuccini.
Lo studioso ha ben intuito il valore fondamentale della «fraternità», se può affermare che «il cappuccino non è più nulla se estrapolato dalla dimensione fondamentale della fraternità» (p. 28). E annota sapientemente: «La fraternità cappuccina è, nei Promessi Sposi, il trascendimento non solo del potere, come libidine umana, ma, radicalmente, dell’avere, come necessità» (ivi).
Un intento dell’autore ben riuscito ci sembra quello di leggere in una prospettiva più vera di umiltà e di carità evangelica le figure minori dei cappuccini de I Promessi Sposi. La figura gigantesca del P. Cristoforo è sempre presente nel critico, ma spesso in relazione e quale riflesso delle figure minori; fra Galdino, fra Fazio, il portinaio del convento di Milano, il guardiano di Monza e quello di Pescarenico, ecc.
Particolare attenzione l’autore dedica ai fratelli laici fra Galdino e fra Fazio con felici illuminazioni interpretative. Interessante questa osservazione, quasi a premessa del suo disquisire: «il fratello laico cappuccino […] è il frate che custodisce l’antico – non solo l’antiquato – e fa da saldatura e mediazione naturale tra i valori rinnovati – in genere espressi dai chierici – e i valori confermati» (p. 56).
Giudizio esatto, che ha avuto una conferma anche nella dialettica post-conciliare nel rinnovamento-aggiornamento dell’Ordine cappuccino.
Il discorso sulla questua di fra Galdino dà occasione al critico di parlare della nota austerità dei cappuccini, con una dovizia di efficaci esemplificazioni, tratte spesso dalla Cronaca di Salvatore da Rivolta, dalla Storia dei cappuccini delle Marche dell’Urbanelli e da altre fonti.
In fra Galdino, così variamente interpretato dai critici, il di Ciaccia coglie anzitutto la semplicità del questuante. Egli nega che il Manzoni voglia contrapporre Galdino a Cristoforo sul piano ideale, anzi la semplicità del primo serve come inquadratura spirituale, nell’ambito della francescanità, all’apostolato del secondo, che pure deve essere semplice per vocazione minoritica.
In particolare discorre sulla presunta «ottusità» di fra Galdino, tanto sottolineata da una critica alquanto tendenziosa con riferimento soprattutto alla fabulazione del miracolo delle noci. Opportunamente il di Ciaccia osserva: «il messaggio manzoniano, attraverso il racconto favoloso in esame, verte sull’‘avventura umana’ della carità, e insieme sulla ‘tranquillità’ che è di coloro che si credono figli di Dio» (p. 70).
E precisa che la favola del questuante cappuccino va inserita nell’ambito della radicale contraddizione, nel romanzo, fra coloro che rapinano, e lo fanno anche offrendo servizi – come Azzeccagarbugli, il Conte zio, ecc. – e coloro che professano il «servizio» anche quando chiedono. Per questo l’autore può asserire: «Ne I Promessi Sposi i cappuccini essenzialmente donano». E più oltre sottolinea che il «servizio» cappuccino verso il prossimo per l’elemosina materiale è «a sua volta mezzo per il beneficio morale. Il valore totale dell’elemosina manzoniana non è senza questo» (p. 75).
In ultima analisi, fra Galdino è visto nell’espansione della carità, in spirito di servizio per il convento e per gli altri, in una cornice di francescana semplicità.
Altrettanta attenzione il critico riserva a fra Fazio, altra figura di fratello cappuccino variamente interpretata a seconda delle diverse angolazioni ideali dei commentatori. Anche in questo caso, come in precedenza, il di Ciaccia denuncia la gratuità di certe affermazioni di Paolo Giudici sui cappuccini nel romanzo manzoniano.
Il Giudici finisce per affermare che «la nota caratteristica di fra Fazio è la superstizione, la più grande, la più marchiana», e che, addirittura, in lui «vediamo tutti i cappuccini d’Italia con la loro superstizione» (p 75-76).
Il di Ciaccia, invece, individua in fra Fazio «la coscienza della norma, attraverso la quale si perfeziona e si evidenzia la coscienza della carità». In fondo fra Fazio è l’uomo del sacrificio ripagato con l’umiliazione, cui egli reagisce con umiltà e affetto.
L’autore può osservare che «se è vero che i cappuccini del romanzo insegnano ad amare, lo insegnano non solo nelle forme mirabolanti, ed eccezionali, come è apparso in genere alla critica superficiale, la quale non ha capito il significato della modestia di alcuni personaggi manzoniani» (p. 86).
Ci sembra che le analisi sui due fratelli cappuccini siano tra le più felici di tutto il saggio, nel quale però non mancano altre valutazioni, sovente inedite. La figura del guardiano di Monza, ad esempio, è colta nella giusta luce del religioso che esprime «affettuosità» verso il confratello amico p. Cristoforo e, per lui, nel servizio verso le due donne toccate dalla sventura; un’«affettuosità» «ignara del mondo nella stessa presunta accortezza».
Anche la diplomazia del padre provinciale è letta in un’ottica nuova: «si tratta della difficile mediazione ‘diplomatica’ in cui il ‘punto’ giusto d’accordo tra brutalità diplomatica e coerenza di carità è un sofferto dilemma» (p. 125).
L’ultima analisi è rivolta ai «cappuccini e la famiglia dell’ucciso», con riferimento alla conversione di fra Cristoforo che si rifugia in convento per sfuggire alla giustizia. Il di Ciaccia definisce l’episodio «uno scombussolamento della quiete cappuccina in un frangente in cui si intersecano un privilegio ‘civile’, una rivendicazione di persone offese e una vocazione religiosa» (p. 125).
Alla fine della lettura del saggio, non sempre facile per il cumulo dei riferimenti bibliografici e dell’incalzare delle riflessioni, si riporta l’impressione di un’analisi ricca e talvolta nuova, dove adesione all’universo ideale del Manzoni, sensibilità critica, vastità di informazione e metodologia mobile nell’utilizzo della filologia e della psicologia anche più aggiornata, ben coesistono per conclusioni persuasive. giuseppe santarelli
Giorgio d’Aquino, Con il “Gran lombardo” dalla parte dei personaggi più umili, «L’Avvenire», 7 luglio 1985, pagina 12.
Tra la ricca produzione critica dedicata in questi ultimi tempi all’opera letteraria di Alessandro Manzoni, ci pare degno di nota il saggio di Francesco di Ciaccia “Gli umili ne ‘I promessi sposi’ ” (Studi e ricerche francescane, Napoli 1984, pagine 126), nel quale l’autore ha voluto dare, col suo contributo, una più ampia ed approfondita visione del mondo dei personaggi manzoniani cosiddetti “minori”, con particolare riguardo alle figure dei frati cappuccini, rivisitate tenendo presente la vita eventuale dell’Ordine così com’era a quei tempi (un’approfondita ricerca d’archivio ha infatti permesso all’autore di rivalutare alcuni personaggi superficialmente studiati dalla critica).
La parte centrale del saggio trova il proprio fondamento nella tematica più generale degli “umili”, all’interno della quale Francesco di Ciaccia è guidato dalla convinzione che per Manzoni l’umiltà sia una virtù che rivela il personaggio, non che lo nasconde. Prendendo in esame varie opinioni critiche riguardanti il tema, l’autore riesce, attraverso un’acuta riflessione personale, a mettere in luce uno dei cardini della morale manzoniana: “La santità non si mette in fila per la parata”. Per il Manzoni lo “scandalo della Croce” costituisce l’esempio più vero della vita del cristiano; ecco dunque indicata la via per capire in profondità il ruolo di Lucia, “madonnina infilzata” secondo il giudizio di Perpetua, in realtà simbolo di umiltà che poggia su una certezza: nella lotta fra verità e ingiustizia, l’ingiustizia risulta” sempre perdente, se non in questa, certo nella vita futura. Il male dunque deve essere combattuto, ma insieme compianto.
Questo saggio, ricco di annotazioni bibliografiche, ci conduce alla riscoperta del messaggio ideale de “I promessi sposi”, mettendoci al coperto dall’incapacità di comprendere e apprezzare tale valore dimostrato dalla critica di stampo materialistico, verso la quale non sono risparmiate pungenti annotazioni, formulate sulla base di un attento e scrupoloso studio del testo manzoniano. [Giorgio d’Aquino]
Mariella Malaspina, Gli umili ne “I Promessi Sposi”, «Letture», anno 40°, quaderno 420, ottobre 1985, pagine 766-767.
Il breve ma densissimo saggio esamina le figure minori dei frati del romanzo manzoniano, sui quali la critica è stata, non senza motivo, povera espositivamente se non proprio, con emblematicità facilmente comprensibile, angusta interpretativamente. In genere, non si è saputo vedere l’immagine degli «umili» manzoniani come segno, e non come significato: cioè come rappresentazione, in simbolo narrativo ed estetico, di un valore evangelico, e non soltanto come sceneggiatura a sé stante del pur rivalutato mondo umano di subalternanza. Intuizioni sul valore degli «umili» manzoniani si conoscevano già in alcuni critici, fra i quali è doveroso menzionare gli specialisti Umberto Colombo, Mario Pomilio, Giancarlo Vigorelli, Angelo Marchese, tra i più recenti. L’angolatura del Di Ciaccia si presenta tuttavia nuova, perché trascende la stessa minorità e mostra come essa sia non negli o degli umili, ma esclusivamente della umiltà; è semplicemente ciò per cui l’uomo si eleva, in quanto «condizione cristica d’esistere e disposizione dell’annunciazione». Da qui le articolate considerazioni analitiche dell’autore, su basi testuali, circa la sapienza e la carità degli umili manzoniani. Le novità di interpretazione, o quanto meno di angolazione, passano attraverso il sarto del villaggio, il Cardinal Federigo, Lucia e Renzo, con un incalzare di riflessioni in ogni caso aderenti al testo, vivisezionato stilisticamente, strutturalisticamente, psicologicamente, così che apparirebbe quasi spiacevole ogni disquisizione accademica.
La prima parte del saggio è tutta occupata da questa introduzione metodologica, esemplificata in molteplici episodi: alla fine essa non dà comunque l’impressione di essere superflua, occasionale, propedeutica (benché impostata non eruditamente, ma ingenuamente) e posta come premessa alla seconda parte, soprattutto per dimostrare la tesi che il senso dell’umiltà, di cui i personaggi sono segno, sta nel suo essere nascosta, celata tra le minuscole pieghe del racconto; non la si può dire esaltandola; si può solo proporla, sommessamente insinuandola. Questo criterio è applicato, nella seconda parte, alla «intuizione manzoniana del mondo cappuccino», studiato non in generale ma nei singoli personaggi minori. Il critico conforta le sue affermazioni con abbondanza di documenti letterari e legislativi della scuola cappuccina secentesca, tra i quali compaiono fonti coeve finora non utilizzate da nessun studioso. Tra i manoscritti riservati dell’Ordine, il Di Ciaccia, pur ignaro, come egli dichiara, di questo settore specifico, ha scoperto consonanze storiche con i cappuccini de I Promessi Sposi. Con prospettazione storicamente ampia, capovolge molte posizioni dei commentatori, coinvolgendo nella disamina, in qualche caso, Momigliano, Russo, Paolo Giudici. Passa quindi in rassegna le mosse, le parole, i silenzi dei personaggi studiati: rivela, ad esempio, la forte obbedienza e carità di Fazio, il sagrestano, che erroneamente si ritiene pensato dal Manzoni come superstizioso e scemo (pp. 76 ss.), o dimostra come la tabulazione di Galdino abbia una manzoniana referenza all’«omogeneità – per dirla con Ezio Raimondi – del tempo di Dio», che non abbandona mai i suoi figli, di contro all’«eterogeneità», e quindi alla discontinuità e problematicità, del tempo della storia (p. 73).
Particolarmente acuta risulta poi l’analisi circa il conflitto ulteriore del padre provinciale, basata su operazioni di critica testuale e comparativa delle successive edizioni del romanzo – come avviene del resto anche per altri episodi – sulla psicologia del senso di colpa e della «coscienza cattiva»: tutto ciò permette all’autore di concludere che non già la «diplomazia» in quanto tale fece condannare il prelato cappuccino da parte del romanziere, ma – pur entro il quadro dell’antipatia manzoniana verso la politica – fu il «compiacimento» del personaggio medesimo per la piega, egoisticamente vantaggiosa, assunta dalla controversia con il potere (p. 120). Numerose sono le pagine sul guardiano di Pescarenico e sulle ragioni della sua riprensione; sul guardiano di Monza, sui meccanismi dell’«amicizia», sulla fenomenologia dell’ingenuità, travestita dai critici precedenti; sui rapporti tra la famiglia nobile dell’ucciso e il guardiano del convento in cui si rifugiò Ludovico, ecc. La complessiva efficacia del libro è conseguita grazie a un’armonica unità tra prospettazione ermeneutica e verifica critica, tra l’articolazione delle disquisizioni e le osservazioni intuitive, tra ambientazione storico-oggettiva e scandaglio letterario, che penetrano fino alle radici dell’universo manzoniano. [Mariella Malaspina]
- [Elena Landoni], «Testo», 10 (1985) pagina 137.
«Molto è stato scritto… sulla predilezione del Manzoni per gli umili. Ma non si è prestata sufficiente attenzione… al fatto che l’umiltà è comunque per il Manzoni il valore religioso più alto, quello supremo…».
Così scriveva, più di trent’anni fa, il Passerin d’Entrèves, con acuta intuizione che affidava però alla critica posteriore il compito di precisare, caratterizzandolo ab intrinseco, il concetto manzoniano di umiltà.
Il recente saggio di Francesco Di Ciaccia si muove appunto in questa direzione, privilegiando in primo luogo i criteri di individuazione della categoria degli umili manzoniani; criteri tutti appartenenti ad una logica che trascende quella puramente umana a cui si è spesso fermata la critica tradizionale, per attingere ad una dinamica inequivocabilmente evangelica. Il fatto che questo sia l’orizzonte entro cui il romanziere colloca con magistrale discrezione il suo brano di cronaca secentesca (ma anche, mi sembra, la riconsiderazione storicamente così ben informata del cappuccinianesimo manzoniano, a cui è dedicata circa metà del saggio), trova a mio parere un’eccellente quanto inoppugnabile conferma nelle Osservazioni sulla morale cattolica. Non certo perché esse costituiscano sostanzialmente, come a tutt’oggi si tende semplicisticamente ad affermare, un’introduzione all’ossatura morale e teologica dei Promessi sposi; ma proprio perché al contrario esse rappresentano, nella forma più sistematica e consequenziale possibile ad un uomo che rimane al fondo più un artista che un teologo, i concetti, le ragioni, gli effetti della morale cattolica da lui a lungo meditati e divenuti il codice di interpretazione e di affronto della realtà.
Vi si incontra già espressa l’idea, che il Di Ciaccia ritrova muovendosi sul piano della critica all’opera d’arte, che l’insegnamento evangelico è da vivere nei poveri gesti quotidiani più che nei momenti clamorosi; l’idea della vita umana come tensione, complessa e problematica, all’ideale dell’annuncio; la consapevolezza che solo la legge divina con la sua logica è veramente adeguata all’uomo e ai suoi bisogni.
Viene da chiedersi quanto della cospicua bibliografia critica manzoniana osservi l’elementare prassi di rispettare il punto di partenza di questa come di ogni altra opera matura dello scrittore lombardo (e per questo non possiamo che approvare i pochi «graffi» qua e là fatti dal Di Ciaccia a qualche critico).
Anche perché, dopo tutta la letteratura spesa al riguardo, mi sembra non sia più lecito fare confusione: una lettura cosciente del mondo ideologico-affettivo dello scrittore, è tutt’altra cosa da una lettura ideologicamente deviante. [L]
Ermanno Paccagnini, La peste e dintorni. Rassegna bibliografica, «Il Ragguaglio librario», Nuova Serie, Anno 53, febbraio 1986, n. 4, pagina 58, recensione comulativa di Francesco di Ciaccia, Gli umili ne “I promessi sposi”, Studi e Ricerche francescane, Napoli 1984, e a Sollecitudine e delirio nella peste manzoniana, Napoli, Studi e Ricerche Francescane, 1985.
Dopo le verriane Osservazioni sulla tortura edite da Serra e Riva a cura di Gennaro Barbarisi e le numerose riproposte della manzoniana Storia della colonna infame, la peste milanese del 1630 ritorna al centro di contributi che affrontano il problema da angolazioni differenti, spesso lontane, talora complementari. Da segnalare innanzitutto la riedizione della testimonianza di Federico Borromeo e del suo De pestilentia quae Mediolani anno MDCXXX magnam stragem edidit: ne è curatore Armando Torno, giovane studioso che non disdegna talvolta sortite dal campo della logica matematica per addentrarsi nel mondo della bibliofilia (suoi un Mirabilia edito da Bocca e una riedizione della Papessa Giovanna del Boccaccio presso la raffinatissima Philobyblon). Il volume borromaico non si presenta quale semplice riproposizione di passate edizioni (Saba del 1932 e Muzzoli del 1962); Torno si è riaccostato al manoscritto federiciano per una nuova lettura, e ne sono significativi segni le varianti che corredano l’opera. Le novità non si fermano qui: meritano di essere segnalate le osservazioni sulla grafia di Federico e sulla sua modalità compositiva; in particolare, le ipotesi sulla grafia del manoscritto del De Pestilentia: contraddicendo tutta una tradizione pro-Federico che va dall’Argelati al Saba, sulla scorta di preziose segnalazioni il curatore propende per l’attribuzione a un segretario, scrivente sotto dettatura. A un volume che si presenta a buon diritto come la più attendibile edizione dell’opera di Federico (corredata di una scorrevole traduzione italiana) Torno premette anche una essenziale quanto puntuale ricostruzione della vicenda umana e culturale del prelato milanese. Tra le numerose opere di questi (e non vanno dimenticati altri due suoi opuscoli di argomento pestilenziale: un ordine al clero e istruzioni al clero e al popolo), un volume più menzionato che letto è il Liber inscriptus Argumenta n. 209, meglio conosciuto come Miscellanea andnotationum variarum: si tratta di un’opera di sapore autobiografico, stesa in forma di appunti a partire dalle ore 21 del 30 ottobre 1594 e corredata di indice analitico composto dallo stesso Federico. Non è facile darne un resoconto, perché si va dalla sentenziosità di un Studia obliterant curas, alla citazione d’autore, alla breve narrazione (cfr. il commosso resoconto della morte dell’amico e padre spirituale san Filippo Neri). L’ardua opera di trascrizione del manoscritto è stata condotta «con coraggio», e con apprezzabili risultati, da un gruppo di studenti coordinati da padre Roberto Caloni, che hanno corredato il volume di una traduzione delle parti latine e di utilissime note esplicative riguardanti i numerosi personaggi ricordati. Federico Borromeo si presenta con aspetti biografici che ascrivono al gruppo dei potenti; non è questo il caso dei cappuccini, che a buon diritto rivendicano il proprio ruolo tra gli umili. In tale veste essi ritornano al centro dell’indagine di Francesco di Ciaccia, che per il suo saggio Gli umili ne «I Promessi Sposi» ha avuto modo di attingere a ricche e inedite documentazioni riservate dell’Ordine cappuccino: ciò gli ha permesso di affrontare un problema, spesso studiato, da un’angolazione diversa e privilegiata, talvolta nuova, e di proporre soluzioni critiche in qualche caso contrastanti con acquisizioni codificate. Oltre che di questo saggio – pur interessante nella disamina delle figure di fra Fazio, fra Galdino, padre Provinciale, il padre guardiano di Pescarenico e quello di Monza –, di Ciaccia è autore di Sollecitudine e delirio nella peste manzoniana. Qui i documenti degli archivi cappuccineschi dovevano essere utilizzati in direzione di più difficile disamina: la figura di Padre Felice Casati e la sua «esperienza di potere» nel governo del Lazzaretto. Non v’è dubbio che la documentazione, abbondante e di prima mano, concorra solidalmente a fornire a padre Felice un’immagine più di servizio che di potere: da una visuale bibliografica il saggio del Di Ciaccia si offre poi come strumento indispensabile per un’indagine completa del settore. A nuocergli è il tono talora pamphletario: suo obiettivo, il discutibile volume di Cordero La fabbrica della peste, costruito sulla tematica a questi consueta dell’opposizione individuo-società. Se dimensione politica vi è stata nella gestione della peste (una peste grande soprattutto per la menzione manzoniana e per la degenerazione processuale a proposito delle unzioni, non certo per il numero dei morti, per le tensioni sociali che l’hanno preceduta o per le conseguenze sull’economia dello stato), se conflitto di potere si è verificato, questo ha interessato un organo quale il Senato, che ha individuato nella peste «l’occasione per riaffermare il suo ruolo egemone nella città e nello stato» e per recuperare il ruolo di primo piano del quale aveva goduto in passato. La prospettiva, nuova nell’ambito degli studi sulla peste del 1630 e di ben altra profondità di indagine rispetto a Cordero (vi risultano nuove acquisizioni d’archivio), è di Romano Canosa, di professione giudice, ma studioso di singoli momenti che concorrono ad una storia sociale della giustizia e dell’impiego dei meccanismi del potere contro «umili» e «oppressi». Dopo uno studioso di diritto come Cordero e un giudice come Canosa, anche il ministro della Giustizia Martinazzoli si è avvicinato al problema-peste: non direttamente, ma attraverso la manzoniana Storia della colonna infame. Il volume dell’editore Grafo Pretesti per una requisitoria manzoniana, corredato da disegni di Giuseppe Repossi, raccoglie, con rielaborazioni e ampliamenti, la lettura del volumetto manzoniano che Martinazzoli ha proposto in più sedi a partire dal convegno di Boario Terme: si tratta di una lettura non solo giuridica (come era lecito attendersi) ma anche culturale (come diveniva doveroso pretendere una volta appreso del suo discepolato presso Cesare Angelini); una lettura soprattutto non disdegnosa di attenzione alle tensioni attuali. «Confesso che, tra i pretesti di queste chiose – confessa Martinazzoli – quello che più mi sollecita verte intorno a un sospetto di inattualità frequentemente sussurrato a proposito di Manzoni. Al contrario, scrive Martinazzoli – e il suggerimento merita certo di essere accolto -, «Bisognerebbe paragonarsi un poco su questo modello: non tanto sulle risposte, ma sul coraggio delle domande, in un tempo che mostra scarse propensioni ad inseguire un pensiero sino in fondo, a verificare, insomma, i nessi che stringono le cause e gli effetti, i comportamenti e gli avvenimenti». E. P.
Lucia Miele, «Esperienze Letterarie», 1 (1986) pagina 141.
La volontà di ricostruire la consistente e ricorrente presenza di un «mondo cappuccino» ne I promessi sposi, narrato dal Manzoni con puntuale ampiezza di documentazione storiografica e con l’accentuazione di peculiarità caratteriali di solenne mansuetudine, guida il Di Ciaccia ad una minuta lettura, corredata da punte spesso polemiche rispetto ai vertici canonici della critica manzoniana, di numerosi episodi che vedono come protagonisti rappresentanti di quell’ordine monastico. Tutto il discorso, puntellato da attenti riferimenti al «contesto storico ed istituzionale del tempo», è inquadrato nella più ampia presenza della virtù dell’umiltà nei personaggi minori e maggiori del romanzo. Essa è opportunamente letta nella sua positiva funzione categoriale di strumento atto ad esprimere fondamentali istanze della visione del mondo del Manzoni, affidate a una pudica predisposizione a svelare importanti messaggi attraverso gesti ed espressioni minime, da cui trapela una particolare accezione religiosa della giustizia, operante direttamente nel sociale.
Nel più recente lavoro del critico si affrontano poi, in due parti distinte, il tema della positività attivistica della ragione e carità rappresentate dalla «sollecitudine» nel flagello della peste come consolatorio contraltare alla follia emblematicamente dominante nella ricostruzione storica della Colonna infame, laddove il «silenzio» dello scrittore trasmette il senso di un’assenza quasi totale di ogni principio di umanità, in cui la pietà è fenomeno isolato e scarsamente significativo sul piano storico. Ne deriva, a saldatura di un discorso critico complesso di molteplici sfaccettature e di andamento volutamente circolare, la possibilità di recuperare, all’interno dell’universo manzoniano, la coscienza di un’assenza di responsabilità della Chiesa nel determinare i presupposti ideologici e culturali della alienante e irrazionale risposta della storia all’episodio della peste. (Lucia Miele)