Moretti, Vito, 2012
Vito Moretti, Luoghi, Note critiche di Daniele Maria Pegorari e Giacomo D’Angelo, Chieti, Tabula Fati (A lume spento 6), 2012, pagine 120, in Literary.it, 5 (2012).
Testo della recensione
In merito alla presente raccolta poetica di Vito Moretti si può stabilire che i “luoghi” da lui “cantati” sono al contempo memorie di esperienze personali, soggettive – a volte della sfera empirica, a volte della sfera esistenziale, soprattutto quando i luoghi rinviano a coinvolgimenti emotivi più profondi, come i luoghi di “casa propria” (per esprimermi con Daniele Maria Pegorari nelle pagine introduttive, L’identità multipla fra permanenze e transiti, p. 9) o quelli legati alle scaturigini del cristianesimo (sotto il titolo di Altri luoghi) – e memorie della storia dei popoli, intessute dal filo delle vaste conoscenze dell’Autore, fino a sconfinamenti che richiamano la mistica – “Ma resta la parola impronunciabile / […] / la voce che non può essere udita / senza smarrimenti” (Sulla strada per Compostela), in cui il “tacere”, “chiudere (la bocca)” rimanda etimologicamente a myein, da cui il termine “mistica”, “mistero”.
Ma se i “luoghi” dell’Autore sono percorsi di vita in cammino, letteralmente, per le contrade del mondo e racchiudono al contempo “la ricerca di un senso all’avventura terrestre” (Giacomo D’Angelo, I “luoghi” di Vito Moretti, p. 89), sottendono anche un concetto filosofico-esistenziale della vita, esplicitamente esposto in quei limpidi versi che forse spiegano il senso del titolo stesso: “Un uomo / ha terra ovunque ed è destino / che varchi le acque e le sabbie, i boschi / cresciuti a dividere” (Viaggio a Odessa).
In ogni caso e per tutto il libro, la scrittura è affidata a versi liberi il cui ritmo dà il senso della colloquialità – “come se [ogni poesia] fosse dettata confidenzialmente”, precisa Daniele Maria Pegorari (p. 10) -, con un esito stilistico di quasi prosaicità, e al contempo dà il senso della classicità epica, perché in realtà la costruzione del verso, effettivamente di elevata “eleganza formale”, “è frutto di una sapiente architettura retorica” (Daniele Maria Pegorari, p. 7 e p. 10).
La struttura di fondo di questa raccolta poetica di Vito Moretti, costituita dal correlativo oggettivo, per cui l’oggetto viene accostato in modo immediato a una sensazione, a un pensiero, a un concetto, applicata in quell’accostamento di oggettività e di soggettività, è ancor più esaltata dalla potenza di immagini che quella struttura favorisce e ingigantisce. La forza di tali immagini è tale, che paiono cariche di un simbolismo che non è di maniera ma che risulta dalla forza stessa delle immagini, come in casi del genere: Bratislava “è prugna / nel buono dei suoi morsi”, è “la foglia caduta alle tue spalle” (Bratislava); “Il lutto canta sulla pietra di ieri” (Berlino); “e veglia perché non torni la cometa / delle burrasche” e “perché restino sgombri / i sentieri agli equinozi dei giusti” (Berlino); “Tutto era scritto sul dorso / delle prede e sul filo di argilla / seccato sulle scarpe” (Berlino); “Berlino è […] un pensiero che la sovrasta e la smarrisce” (Berlino). E se Teufelsberg, la collina delle macerie, ha un immediato rapporto di senso nell’espressione “rovine da ricordare”, lo ha in modo indiretto nell’altra frase, “ha scale di tante case”, in quanto rimanda alle scale delle case abbattute, delle quali appunto la collina attuale è costituita (Berlino).
Si assiste sempre ad una stretta coesistenza tra la materia storica e la sfera della quotidianità, l’una e l’altra espresse con la medesima semplicità e con il medesimo lirismo classico. Si prenda, ad esempio, il brano di Sulle rive del Brenta in cui si fa riferimento alle scorribande degli opposti governi di Padova e di Venezia, con i relativi saccheggi e le connesse ruberie, e al transito delle imbarcazioni veneziane, con il loro carico nobiliare e il codazzo di accompagnatori cicisbei destinati a rallegrare le ore con canti, suoni e “baci finti”. Il ricordo di eventi o fasi della storia sono sguardi sul passato che si accompagnano a quelli con i quali si guarda all’“ora”, al momento attuale in cui si colloca la scrittura, sì che l’una e l’altra dimensione temporale quasi si annullano compenetrandosi a vicenda.
La compenetrazione tra l’ambiente oggettivo e lo stato d’animo, tra il mondo esterno – con attenzione persino ai particolari più minuti (“L’orologiaio dalle orecchie larghe”, I volti di Dublino, o il fante “che ride sulla murata del fiume / e ciondola i piedi”, Il ponte di Margit) – e il dato personale è tale, che l’autore transita dall’uno all’altro con assoluta immediatezza. Ad esempio, a Montmartre si passa dal fiatone a metà gradinata – quando l’autore lascia che “altri giungano prima” alla sommità del colle – allo sguardo panoramico sulla città, e da questo a Mallarmé, con riferimento ad una sua espressione (“ogni sguardo è un colpo di dadi”), e a squarci di storia cristiana antica (A Montmartre) – e così a Dublino, con le consuetudini vikinghe e le reminiscenze di letteratura irlandese accanto a scorci di quotidianità (“e un’anziana donna porta il suo cibo / ai gatti, li chiama per nome / mentre fuma e ride sull’aiuola”, I volti di Dublino); o, a Bratislava, la descrizione di siti precisi (“Porta San Michele”, “l’orologio / di Piazza Centrale”, il “Kafé-Mayer”) e di dipinture urbane (“il filo di gerani / che orla il ricciolo dei balconi”) strettamente seguite (dopo un punto fermo, ma a seguire nel medesimo verso: ciò a conferire il senso della colleganza ideativa tra l’epos e il quotidiano) dalla menzione autocronistica: “Sul tavolo bianco / si fa distratta la mia mano, / consuma tutta l’acqua / la mia sete”) (Bratislava); o a Odessa: Anna Achmatova, poetessa, e Isaac Babel, scrittore, sono sullo stesso piano di episodi di vita quotidiana, minimale: “Al mio fianco / un passante mi chiede fuoco / per il suo sigaro […] / […] il suo sorriso / fa festa agli spiccioli urbani / della mia gentilezza”, con il racconto, poi, dei marinai che, scesi dalla nave, spendono il danaro nelle osterie in cui “si mangia / nel canto della giovinezza” (Viaggio a Odessa).
Il “narrare” la storia (come nell’“epos dell’Omero odissiaco”, per esprimermi con Giacomo D’Angelo, p. 89) con il registro stilistico della quotidianità colpisce particolarmente in un brano quale quello intitolato Ad Auschwitz. Il “canto” presenta una semplicità disarmante – quasi si trattasse di una passeggiata in campagna da parte di qualche pensionato tranquillo e sereno -, ma bastano alcuni lessemi e bastano alcune inflessioni verbali – in aggiunta alla posizione enfatica di qualche sintagma – a far venire i brividi sulla pelle e un tonfo al cuore: “Non ci furono passeri […] né […]”, “scendeva sghembo”, “ma cenere […] e polvere”, “il vento restituiva”, e, più cronachistico, “dal camino che divorava le ossa”. Se poi il pensiero si fa esplicito, la scrittura continua ad essere descrittiva, ancora scolpita sulla roccia, come: “In pochi passi / trovava compimento l’ordine osceno / dell’infamia e dell’odio e si faceva specchio / il fondo più nero, opera / la tenebra venuta col fiato dei dèmoni” (in cui una semplicissima espressione sintagmatica – “fiato dei dèmoni” – catapulta di peso l’animo nostro nella profonda bolgia dantesca dei traditori, in cui il fiato di Lucifero raggela l’aria, le lacrime e il cuore).
Ma ancora vorrei sottolineare come alcune successive espressioni della medesima strofa traducano, in forti sintesi semantiche, il nucleo del concetto intellettuale, sì che non pare esserci distanza tra l’espressività e la concettualità – per cui l’eidos si fa phantasma -, come in quelle “rughe” d’inganni e in quell’“ombra” adagiata dei “disperati silenzi”.
Più in generale, è tutta la scrittura di queste poesie di Vito Moretti che sembrano stagliate quali incisioni sulla pietra – come la chiesa “di pietra costruita col sasso” (Nell’eremo di fra Nicola) – e mi fanno venire in mente un altro poeta della roccia e del vento, in questo caso garganici: Giovanni Scarale, cantore di Pio da Pietrelcina. Il risultato globale di siffatta tonalità scrittoria è, come s’è capito, una poesia che scolpisce ogni singola immagine mentale, ogni singola ideazione direttamente sul duro sasso e solo da lì arriva al lettore. Non c’è quindi emozione, non c’è effusione né pathos, nel senso che non c’è l’apparire di tutto ciò: tutto ciò non si presenta e non si offre direttamente – la pietra infatti è dura e aspra -; tutto ciò si trova, invece, scolpito come in altorilievo marmoreo. Qualche concessione all’emotività esplicitata, ovvero qualche invasione nell’area del sentimento elicito (come in “Nessuna pena si cancella”, Ad Auschwitz), si reincarna in immagini corpose quali quelle dei “gomitoli spezzati”, di quell’“angelo dei dirupi” e di quei “vetri ancora aguzzi” di montaliana ascendenza (concettuale oltre che lessicale).
La caratteristica della poesia di Vito Moretti, quale appena indicata velocemente, si rinviene nella stessa modalità dei ricordi dei luoghi – che dà appunto il titolo alla raccolta.
Se i luoghi costituiscono tappe di esperienza e di formazione della persona, anche essi sono rappresentati come in altorilievo: sono sempre immagini materiche quelle che vanno a raccontare l’avventura del vivere. A Santa Maria di Pagliara, ad esempio, le foglie cadute “a celare l’impronta dei tuoi sandali” narrano, sul marmo in altorilievo, la sollecitudine cercata e voluta dall’eremita Nicola; o il talco, “che rese lunga la carezza / sulle mani” delle demoiselles di Parigi, canta tutto il mondo di sogni e di batticuori dell’età in fiore (Lungo la Senna).
La potenza di certe immagini è abissale, quasi stordisce; e, se è vero – come è vero – che la poesia di Moretti è lontana dall’ermetismo di imitazione – poiché “La sua musa «dai semplici panni» rifiuta l’oscurità dei simboli e gli arzigogoli orfici” e “il suo canto non s’impiglia in cifre ermetiche” (Giacomo D’Angelo, p. 90) -, certamente, d’altra parte, il testo è tutto una contiguità tra la cifra del quotidiano – sempre espresso in brevità sintattica e in levità stilistica, mediante pennellate impressionistiche – e la densità delle simbologie espressionistiche. Si leggano versi quali “il verde distratto di un pino”, “un luogo da nulla”, “l’esca / al capriccio d’un niente” (Sotto il cielo di Provenza) – che esprimono plasticamente l’aridità del luogo, proiettabile su una aridità esistenziale -, o “la pazienza che ha la carne sudata” – che connota un atteggiamento interiore con la fisicità del sudore che cola sulla pelle! Sono espressioni così potenti, taglienti, impressionanti, che sembra debbano trascendere il significato letterale e proiettarsi verso significati ulteriori. Immagini di questo spessore – tra il plastico marmoreo, petroso e il simbolico espressionistico – si incontrano di continuo, con espressioni di tal fatta: “strade / che lo chiamino al giro delle penombre / e delle promesse”; “e la piazza è ritrovo di anime / che sanno delle ustioni / lasciate al giro dei rimorsi” (Viaggio a Odessa); o “Dublino”, che “tiene a bada le sue nebbie / e getta la sciarpa sul suo angolo / di creato” (I volti di Dublino).
Il presente testo poetico di Vito Moretti richiede, certamente, una lettura attenta ed accorta, per la sua pregnanza concettuale – che esige preparazione culturale ed estetica di alto livello -; con questo presupposto, risulta godibilissimo la sua ricchezza di immagini, per la sua vasta gamma di informazioni e per la sua classica linearità espositiva.

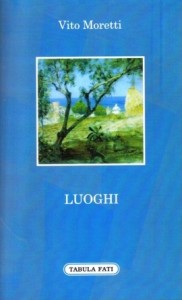
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.